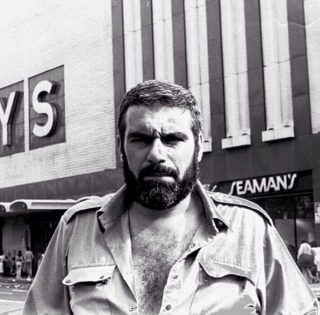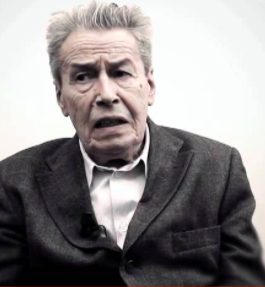sabato 26 Maggio 2018
Lo scrittore e architetto Aldo Buzzi era amico del disegnatore Saul Steinberg, e una volta, erano insieme, Buzzi fissava il forno, dentro il quale cuocevano delle capesante, e sembra che Steinberg gli abbia detto «Il forno è la tua televisione», e che Buzzi abbia risposto «Ho un debole per le capesante», e che Steinberg abbia detto «Tu hai un debole per quasi tutto». E Un debole per quasi tutto è diventato il titolo di una raccolta degli scritti di Buzzi nella quale si legge un dialogo tra lo stesso Buzzi e un signore anonimo che dice: «Ho preparato una proposta da sottoporre al ministro della giustizia per punire una categoria di persone che mi dà fastidio in modo particolare.» «Per esempio?», chiede Buzzi. «Per esempio quelli che, dopo aver nominato New York, se devono nominarla una seconda volta, dicono la Grande Mela. Per questi la pena dovrebbe essere l’ergastolo». «Accidenti!». «Sì, ma non solo per questi. Anche per quelli che, dopo aver nominato il dollaro, se devono nominarlo una seconda volta, dicono il biglietto verde; o, se devono nominare l’oro una seconda volta, dicono il metallo giallo. E stessa pena per quelli che dopo il pallone, invece di ripetere il pallone dicono la sfera di cuoio. Ergastolo senza le solite riduzioni di pena» aggiunge il signore. «E per quelli che dicono il papa – una paroletta breve che fa risparmiare tempo e fatica – e poi si buttano su Giovanni Paolo Secondo?». «Ergastolo» dice Buzzi. «Bravo. E per quelli che, dopo aver nominato Gelli, aggiungono sempre l’ex maestro venerabile della loggia P2?». «L’ergastolo come sopra» dice Buzzi. «No, la fucilazione. Sto lavorando anche a un’altra proposta per punire tutti quelli che invece di ‘i gnocchi’ scrivono ‘gli gnocchi’. Non c’è nessuna difficoltà a pronunciare i gnocchi, come non ci sono difficoltà a pronunciare ignoto, ignorante, ignobile». «Ahi! Ahi! E chi introduce nei cervelli queste assurdità?». «Sono certe maestre… le figlie di quelle che un tempo insegnavano a scrivere: ‘carne in iscatola’. Mi ricordo una carne in iscatola che era rimasta nelle prime pagine di Tempo di uccidere di Flaiano. Ho sostituito l’iscatola con una normale scatola e Flaiano mi ha ringraziato. La saluto. Parto. Vado in Isvizzera… Non si agiti. Sto scherzando. Buon lavoro».
Una delle cose che ho raccontato più spesso, nei miei interventi pubblici, è lo stranissimo caso della prima traduzione italiana del romanzo dell’americano Bret Easton Ellis American Psycho. In questo romanzo, nella prima pagina, compare tre volte la parola «Bus», che significa, come si sa, «Autobus». Nella prima traduzione italiana di American Psycho, il traduttore aveva tradotto il primo Bus con «Autobus», il secondo con «Corriera», il terzo con «Torpedone».
Perché ha fatto così, quel traduttore, perché a scuola, la maestra, per capire il bagaglio lessicale degli allievi diceva di non fare ripetzioni e di usare dei sinonimi. Ma che bisogno ha, Bret Easton Ellis, di mostrare il proprio bagaglio lessicale? E che sinonimo sarebbe, di autobus, corriera, che sappiamo benissimo che sono due cose diverse? Quanto a torpedone, ho raccontato di questa traduzione a un mio conoscente che mi ha detto che se lui leggesse, in un romanzo, la parola «torpedone» gli verrebbe da pensare che è successo qualcosa di brutto. È una parola che mette in agitazione, torpedone, lasciamola stare. Anche perché, quel torpedone lì, alla fine della pagina, è sempre lo stesso autobus che c’era all’inizio. Stiamo calmi. Solo che noi, l’unico posto in cui scriviamo tutti, è la scuola, e siamo convinti che la scrittura, e la letteratura, sia una cosa che ha a che fare con le regole che ci hanno insegnato a scuola, e quando cerchiamo di scrivere una cosa letteraria, per prime applichiamo le regole del bello scrivere (scolastico) prima tra tutte, forse, questa di non fare ripetizioni, come se la ripetizione non fosse una figura retorica come le altre che, se la si usa bene, può essere potentissima. Io ho avuto la fortuna di tradurre, e di leggere in pubblico più di una volta, un libro straordinario, La morte di Ivan Il’ič, di Lev Tolstoj.
Tolstoj, in quel libro lì, ci fa vedere la morte di Ivan Il’ič come se vedessimo la morte per la prima volta, e benché questo Ivan Il’ič sia un funzionario antipatico, odioso, senza nessuna particolare qualità umana e intellettuale, la sua morte ci sgomenta, ci fa male, e, in quel racconto, Tolstoj usa la parola «morte» come se non fosse una parola, ma un martello. Ci picchia, con la «morte», ce la ripete in faccia tante di quelle volte che ci fa male. E io, da traduttore, che servizio avrei reso, a Tolstoj, se, in qualche caso, avessi cambiato la sua «morte» con «dipartita»? O se, invece della «Morte di Ivan Il’ič», avessi intitolato il libro «Il caro estinto Ivan Il’ič». Non sarei stato bravo, secondo me.
C’è un poeta straordinario, di Santarcangelo di Romagna, si chiama Raffaello Baldini, scriveva delle poesie in dialetto, e le traduceva lui in italiano, e venivano fuori delle cose così: «Ventitré anni, carina, innamorata, | ma i suoi non volevano, suo padre delle scenate, | per settimane, mesi, una guerra, lei | sempre più innamorata, e l’altra sera | è andata a letto presto, si è chiusa in camera, | e la mattina non s’è svegliata più. | Che uccidersi non va bene, non si può, però | ‘sta bambina, adesso, come farà il Signore | a mandarla all’inferno?». L’artefice della fama di Baldini, l’attore Ivano Marescotti, che andava in giro a recitare le sue poesie e che l’ha convinto a scrivere i testi teatrali che gli hanno dato la popolarità che adesso ha, racconta che una volta ha letto delle poesie di Baldini in Romagna e che, alla fine, una signora lo è andato a ringraziare e gli ha detto «Mmi son piaciute tanto, ma tanto, ma eran così belle, ma così belle, non sembravano neanche delle poesie». Ecco io, una volta, undici anni fa, ho fatto l’attore, in teatro, e il mio regista, un grande regista, Gigi Dall’Aglio, la cosa che mi diceva più spesso, durante le prove, era: «Non recitare». Allora, l’altra volta abbiamo detto che William Somerset Maugham diceva che ci sono tre regole, per scrivere un romanzo, e che, purtroppo, nessuno sa quali siano. Questa volta aggiungiamo che se il romanzo che avete scritto, o che state scrivendo, non sembra un romanzo, non è detto che sia un brutto segno.
[Uscito ieri sulla verità]

sabato 19 Maggio 2018
Lo scrittore inglese William Somerset Maugham ha scritto una volta: «Ci sono tre regole, per scrivere un romanzo. Purtroppo, nessuno sa quali siano». Credo che abbia ragione.
Un altro scrittore britannico, Roald Dahl, in un racconto intitolato Lo scrittore automatico, immagina che un informatico con la passione per la letteratura, che si chiama Knipe, proponga al suo capo, che si chiama Bohlen, una macchina per scrivere racconti e romanzi.
«C’è una cosa che proprio non capisco, Knipe. – dice Bohlen – Da dove uscirebbero le trame? Una macchina non può inventarle».
«Gliele forniremo noi, signore – risponde Knipe – Nessun problema. Ce ne sono tre o quattrocento scritte nella cartelletta alla sua sinistra. Le collochiamo dritte nella sezione ‘memoria trame’ della macchina».
«Continui».
«Sono previste anche molte altre piccole raffinatezze, Mr Bohlen. Le vedrà quando studierà il progetto nei particolari. Per esempio, è previsto un espediente che usano quasi tutti gli scrittori, quello di inserire in ogni racconto almeno una parolona lunga e incomprensibile. Questo fa pensare al lettore che l’autore sia molto dotto e intelligente. Perciò la macchina farà automaticamente lo stesso. Avremo un intero stock di parole lunghe memorizzate».
«Dove?»
«Nella sezione ‘memoria parole’» rispose epesegeticamente Knipe», scrive Dahl (la traduzione è di Massimo Bocchiola), anche se quell’epesegeticamente ci fa sospettare che questo racconto non si debba necessariamente a Dahl ma, forse, alla macchina di Bohlen. Che è una macchina, però, che, nella realtà, non credo nessuno abbia ancora inventato. Perché Ci sono tre regole, per scrivere un romanzo, e nessuno sa quali siano, e siamo d’accordo.
Eppure io, da una dozzina di anni, tengo delle scuole di scrittura in cui insegno a scrivere dei romanzi. Son matto? Forse sono anche matto, ma credo che quello che faccio, le scuole di scrittura alle quali partecipo, non siano insensate come potrebbe sembrare.
Quando avevo sedici anni mi piaceva disegnare, al pomeriggio mi mettevo nella mia stanza e stavo lì un’ora a copiar dei fumetti e mi piaceva moltissimo lo stato della mia testa in quei momenti lì che copiavo, mi sembrava una cosa sana, che faceva della mia testa un posto pulito.
E siccome non sapevo niente, della tecnica del disegno, avevo comprato una di quelle dispense che vendevano in edicola, un corso di disegno, avevo preso il primo numero e avevo cominciato a leggerlo e, visto che non la conoscevo, io mi immaginavo che mi avrebbero insegnato la tecnica, che matite usare, come fare il chiaroscuro, dove cadon le ombre a seconda della fonte di luce, però poi leggendo, la prima cosa che c’era scritta in quel corso di disegno era il fatto che, sì, mi avrebbero insegnato la tecnica il chiaroscuro eccetera eccetera ma soprattutto, quel che volevano insegnare a quelli che avrebbero fatto quel corso, sarebbe stata la cosa più difficile da imparare, per imparare a disegnare, dicevano loro, cioè guardare.
Che io mi ricordo mi ero sentito imbrogliato. “Cosa sono andato a comprare?” avevo pensato, perché ero convinto di esser capace, di guardare, eran sedici anni, che guardavo, solo che poi, ero andato avanti a leggere, loro mi proponevano di fare una prova, quelli che avevano scritto quel manuale lì di disegno.
«Prova a pensare a una persona che vedi spesso e che non è con te in questo momento – c’era scritto, – prova a pensare alla sua testa, che forma ha? È ovale o tonda? La linea delle orecchie è sopra o sotto quella delle sopracciglia? Che distanza c’è tra l’attaccatura dei capelli e la radice del naso? E tra la fine del naso e il labbro superiore? Gli occhi come ce li ha, distanziati o ravvicinati?»
Io avevo pensato al mio compagno di banco, che si chiama Bruno Pelosi, e non avrei saputo rispondere a nessuna di queste domande. Avrei saputo solo dire che Bruno era biondo e aveva gli occhi azzurri. Ero così convinto di sapere com’era, il mio compagno di banco, che non lo guardavo: Bruno mi stava di fianco, tutti i giorni, nel suo imballaggio da compagno di banco, come se fosse ricoperto da del pluriball, quelle buste trasparenti con dei pallini pieni d’aria che mettono intorno agli strumenti elettronici quando li imballano, su cui ci fosse scritto: «Bruno Pelosi, compagno di banco».
Il giorno dopo, ero andato a scuola l’avevo guardato e avevo visto Bruno Pelosi.
L’avevo visto fuori dall’imballaggio, come se accorgermi che non avrei saputo descriverlo fosse servito a sfilargli il pluriball, e mi ero accorto che aveva gli occhi molto ravvicinati, forse è la persona con gli occhi più ravvicinati che abbia conosciuto in vita mia, ma forse no, che c’è una bibliotecaria, in provincia di Milano, che ho incontrato qualche anno fa, che secondo me ha gli occhi ancora più ravvicinati.
In un libro che è una specie di involontario manuale di scrittura e che si intitola Nel territorio dei diavolo, Flannery O’Connor scrive: «La narrativa opera tramite i sensi, e uno dei motivi per cui, secondo me, scrivere racconti risulta così arduo è che si tende a dimenticare quanto tempo e pazienza ci vogliano per convincere tramite i sensi. Se non gli viene dato modo di vivere la storia, di toccarla con mano, il lettore non crederà a niente di quello che il narratore si limita a riferirgli. Ho un amico che sta prendendo lezioni di recitazione, a New York, da una signora russa che ha fama di essere un’ottima insegnante. Mi scriveva questo mio amico che per tutto il primo mese non hanno pronunciato neanche una battuta, ma solo imparato a guardare. Imparare a guardare, infatti, è la base per l’apprendimento di qualsiasi arte, tranne la musica. Molti dei narratori che conosco dipingono, non perché siano particolarmente dotati, ma perché dipingere li aiuta a scrivere. Li costringe a osservare le cose» (la traduzione è di Ottavio Fatica).
«Personalmente – continua la O’Connor – affronto i problemi letterari proprio come faceva la governante cieca del Dottor Johnson quando versava il tè: metto il dito nella tazza».
Ecco noi, in una serie di pezzetti che saranno ospitati dalla Verità (grazie) proveremo anche noi a affrontare i problemi letterari come faceva la governante cieca del Dottor Johnson: mettendo un dito nella tazza.
[uscito ieri sulla Verità]

lunedì 5 Marzo 2018

Tengo, da anni, una scuola di scrittura che si chiama Scuola elementare di scrittura emiliana e, da anni, per chi ha già fatto la scuola elementare faccio delle Scuole medie di scrittura emiliana, e in questo periodo sto facendo, a Milano, una Scuola media di scrittura su Michail Bulgakov: leggiamo dei racconti e dei romanzi di Bulgakov, ne parliamo, e chiedo ai partecipanti di scrivere delle cose che hanno a che fare con quel che ha scritto Bulgakov. La scorsa settimana, avevamo parlato della lettera che Bulgakov, nel 1930, scrive a Stalin dopo che le sue opere sono proibite. «Passando in rassegna i miei ritagli di giornale, – scrive Bulgakov, – ho constatato di aver ricevuto dalla stampa sovietica, nei dieci anni della mia attività letteraria, 301 recensioni, di cui 3 favorevoli e 298 ostili e ingiuriose» (la traduzione è di Mario Alessandro Curletto). Poi Bulgakov chiede o che lo lascino lavorare, o che gli permettono di andare all’estero. Sembra che Stalin, che dicono avesse visto una dozzina di volte I giorni dei Turbin, l’opera teatrale che Bulgakov aveva tratto dal proprio romanzo La guardia bianca, dopo qualche giorno abbia telefonato a Bulgakov e gli abbia detto che non era il caso che andasse all’estero e che gli avrebbero trovato da lavorare, e, con l’interessamento di Stalin, glielo trovarono davvero, allo Mchat, il teatro moscovita fondato da Stanislavskij. Allora io, come compito, ho chiesto ai partecipanti alla scuola media di scrivere una lettera a Gentiloni, e il mercoledì dopo ho ascoltato le lettere che avevano scritto e ho detto loro di questa serie di pezzi sui politici che avrei scritto per la Verità, e gli ho detto che avrei voluto finire con Gentiloni e che mi sarebbe piaciuto citare le loro lettere e loro, gentilissimi (o Gentilonissimi, come si legge in una di quelle lettere), mi hanno dato l’autorizzazione a usarle. Ho saputo, da quelle lettere, un po’ di cose che non sapevo, di Gentiloni, per esempio che appartiene alla famiglia dei conti Gentiloni Silveri, che è imparentato con Vincenzo Ottorino Gentiloni, responsabile del Patto Gentiloni, che ha determinato l’ingresso dei cattolici nella vita politica italiana, che è stato maoista, in Democrazia proletaria e, con Rutelli, nella Margherita. Non posso mettere tutte e 17 le lettere che son state scritte, ne citerò solo due. Domenico, il primo, scrive: «Io, di quello che tu hai combinato in questi ultimi mesi, cioè da quando ti hanno messo al governo al posto di quell’altro che ha perso il referendum, non so assolutamente niente. Io ti ho solo visto per sbaglio qualche volta alla televisione, ma se avessi parlato alla radio, non avrei riconosciuto nemmeno la tua voce.
Non potendomi lamentare per il tuo operato, ho pensato che forse potrei indirizzarti almeno qualche supplica. Mi piacerebbe poterti chiedere, ad esempio, come ha fatto Bulgakov con Stalin, di lasciarmi lavorare in santa pace, o in alternativa di permettermi almeno di lasciare il Paese, con tutta la famiglia. Ma a me, il fatto di lavorare in santa pace, mi fanno lavorare. Nessuno mi dice niente, ti assicuro. Per quanto riguarda andare all’estero, io e mia moglie invece, per il momento non abbiamo tanta voglia. Stiamo bene qui a Milano, siamo felici, il mese scorso ci siamo presi anche la macchina».
Ci sarebbero poi molte altre belle lettere, da citare, ma siccome ne voglio pubblicare una intera, c’è spazio solo per quella, la lettera di Luisella, con la quale chiudo questa serie di dieci pezzi sui politici, che mi è molto piaciuto scrivere, e per la quale ringrazio la Verità e i lettori che mi hanno sopportato tutti i giorni per così tanti giorni di fila.
«Gentile Presidente del Consiglio, le scrivo per descriverle un po’ l’Italia. Credo sia difficile pensarlo questo Paese quando si vive in un palazzo che ha il tuo stesso cognome. 100 passi da Palazzo Chigi. E da lì, da quella casa, credo che si faccia fatica a pensare a come si sta qui, dall’altro lato della strada. A volte mi domando se in quella sua bella casa, e in quella di altri politici, ci siano gli specchi in bagno. Ci saranno i bagni , no? Anche da voi. E si farà la barba o se la fa fare a Palazzo Chigi? Un giorno ho letto che la retribuzione di un barbiere di Palazzo Chigi supera i 120.000 euro, i rasatori e acconciatori dei deputati sono qualificati come operatori tecnici. Forse è questo il problema, non farsi la barba a casa, non guardarsi allo specchio in bagno e non stare soli con se stessi. Quei gesti lì, alzare il mento, il sopracciglio destro e poi quello sinistro. Potrebbe esserci un momento di verità. Ma ripeto è difficile pensare al Paese quando si vive in un palazzo che ha il tuo stesso cognome, anche se al liceo ci si firmava Paolo e nella O la falce e martello. Adesso rimane solo il martello con il quale sono state distrutte, certo non solo è colpa sua, tante cose per esempio la Scuola, il Lavoro, la Sanità.
Ho iniziato a capirlo quando si è smesso di chiamare il Primo Maggio la festa dei lavoratori ed è diventato la festa del Lavoro. Così generico. Lavoro come Sole Cuore Amore. Niente quindi. E in generale a chiamare le cose in inglese tipo giobszach. Non so a un certo punto è come se vi fosse venuta vergogna a chiamare le cose con il loro nome. A parlare di lavoro, di operai, di sciopero. E insieme al lavoro, la Scuola. Mica è un caso eh… e pensare che proprio oggi è un momento storico in cui studiare, allenare il pensiero critico, allenarsi alla complessità sarebbe importante per affrontare un mondo del Lavoro, appunto, che cambia ogni 15 giorni. Quando vedo tirare un’altra martellata alla Scuola mi viene in mente uno dei contadini di Fontamara. Il padrone gli aveva detto che il campo sarebbe stato diviso in due: ¾ ai contadini e ¾ al padrone. Uno a cui non tornavano le cose aveva detto che se c’era guadagno per padroni e contadini c’era un inganno. E che comunque ai cafoni “erano impediti i ragionamenti”.
Ecco distruggere la Scuola è questa cosa qui. Ci pensi». Firmato: Luisella.
[uscito ieri sulla Verità]

domenica 4 Marzo 2018

Mi era sembrato strano il comportamento di Pierluigi Bersani, che ha fatto una campagna elettorale tutta in sordina, non l’ho mai sentito nominare, probabilmente ha fatto pochi comizi, ho pensato, è andato poco in televisione, poi sono andato a cercare, ho trovato che invece qualche intervista televisiva l’ha fatta; il 27 febbraio, per esempio, pochi giorni fa, era da Lilly Gruber in un programma che si chiama Otto e mezzo dove lui ha detto che tutti gli chiedono «Ma dove sei andato a finire?» e che lui risponde «Io son sempre stato qui, sono loro, che si sono spostati».
E ha detto che, per lui, l’esperienza di questa campagna elettorale è stata molto positiva, che «la gente è venuta, è uscita dal bosco», e che, secondo lui, la nascita di Liberi e uguali, che è il movimento con il quale si presenta alle elezioni, è stata presa molto bene, che lui trova solo «del popolo che è contento, perché non sapeva dove andare, e adesso dice “Siam qui, è tornata la sinistra”, adesso c’è anche il vento siberiano, non pretendevo tanto», ha concluso poi Bersani l’altro giorno.
Che io, a parte il fatto della gente che esce dal bosco, stavano in un bosco? ma parte quello, che non l’ho tanto capito, devo dire che non ho capito neanche tanto il fatto che lui, Bersani, sia uno che è sempre rimasto lì dov’era.
Io invece ho l’impressione che il principale partito della sinistra, nel quale Bersani ha fatto politica per tanti anni, quel partito lì che quando Bersani è stato eletto consigliere comunale a Bettola, in provincia di Piacenza, nel 1985, il partito di Bersani, allora, nel 1985, si chiamava Partito Comunista Italiano, e è cambiato ininterrottamente, dal 1985 ad oggi, quel partito lì, come testimonia anche il cambiamento dei nomi ultimo dei quali Partito Democratico.
Ecco, il Partito Democratico, l’ultima volta che si è presentato alle elezioni politiche, nel 2013, il suo leader era proprio Bersani, e quella campagna elettorale, io, non che l’avessi seguita tantissimo, ma me la ricordo soprattutto per un video: sul terrazzo di un edificio che si immagina romano, un gruppo di signore e signori di spalle, guidati da due vestiti come uno che non ne sa tanto si può immaginare che siano vestiti dei dee-jay (io non ne so tanto e me li immagino vestiti così, gli uomini in nero, con i capelli lunghi e la barba, e una collana al collo e una catena che esce da una tasca, le donne in nero con gli occhiali da sole e degli elementi di viola e degli stivali un po’ aggressivi, da dee-jay), queste signore e questi signori fanno un saltello su se stessi, si trovan di faccia, si battono i palmi delle mani sulle cosce e cominciano a ripetere, in coro: «Lo smacchiamo, lo smacchiamo, lo smacchiamo, lo smacchiamo, lo smacchiamo». Quello che avrebbero voluto smacchiare, elegante metafora per battere, umiliare, annichilire, era il loro avversario politico, il giaguaro, che oggi, cinque anni dopo, alle elezioni politiche successive, è ancora lì, con tutte le sue macchie, che son tante, secondo me.
Io, Bersani, anzi, più che sembrarmi uno che è sempre rimasto lì, lo collego proprio a questo continuo cambiamento, perché mi ricordo il suo comizio di chiusura della festa nazionale dell’unità del 2012, al Campo Volo, di Reggio Emilia, che all’orario in cui doveva cominciare, il comizio, non c’era nessuno, a sentire, allora è stato rimandato di qualche ora, e quando ha cominciato a ammucchiarsi un po’ di gente, dei ragazzi con dei giubbetti neri e la scritta, dietro la schiena, Staff, si sono messi a distribuire delle bandiere e dei cappellini che non erano rossi, come le bandiere e i cappellini della festa dell’unità e del PCI, avevano i colori del PD, bianco, rosso e verde (gli stessi colori del partito del Giaguaro), e quando poi Bersani era arrivato, la prima cosa che aveva detto, a quel comizio, non era stata «Buongiorno», o «Salve», o «Cari compagni», o «Amici cari», era stata: «Care democratiche, cari democratici».
Che io mi ricordo mi sono chiesto “Ma come si fa, dopo un inizio del genere, a dire qualcosa di sensato?”.
E ero andato via, ero andato al ristorante a mangiare, che intanto Bersani aveva finito, chissà cosa aveva detto, e dopo che io avevo mangiato quelli del ristorante si eran messi a cantare Bandiera rossa e l’ultima strofa non avevan cantato, come da testo di Bandiera rossa, «Evviva il comunismo e la libertà», avevano cantato «Evviva il PD, e la libertà».
Cioè si era spostato tutto, altro che restare al proprio posto, si era spostato tutto fin da allora, fin dal 2012, quando comandava Bersani, e adesso, se dovessi dire un politico che mi ricorda Bersani oggi, io direi Achille Occhetto, che dopo la svolta della Bolognina, e dopo aver perso le elezioni politiche del ’94, era tornato in pista nel 1998 con un libro intitolato Governare il mondo, che aveva presentato con un giro alle feste dell’unità e, quando dagli altoparlanti si diceva che, al tendone della libreria, l’onorevole Achille Occhetto stava per cominciare a parlare del libro Governare il mondo, ti correva un brivido lungo la schiena, se così si può dire.
[Uscito ieri sulla Verità]

venerdì 2 Marzo 2018

Oggi non parliamo di un politico ma di un concetto che, inaspettatamente, per me, per lo meno, è al centro della campagna elettorale: l’antifascismo. È una parola semplice, apparentemente chiara, ma è una di quelle parole che, per lo meno per me, ha cambiato il suo significato nel corso degli anni.
Io sono nato nel 1963 e quando ero piccolo, negli anni settanta e ottanta, antifascismo, e la parola ci andava insieme, resistenza, erano parole che sentivo dire dai palchi e dalle tribune dei politici, e che io non credo di avere mai pronunciato: allora non lo sapevo, ma qualche anno dopo avrei letto un libro di uno degli ultimi dissidenti sovietici, Aleksandr Zinov’ev, dove, tra le altre cose, veniva enunciava una legge che, secondo Zinov’ev, governa le nostre società: «Tutto quello che è ufficiale, è falso».
Quando ho letto questa cosa di Zinov’ev, mi è sembrato che questa fosse una legge che valesse sia per i discorsi e per i documenti prodotti dai governanti, che per i discorsi e i documenti prodotti da me in certe situazioni particolari. Quando avevo vent’anni, per esempio, e cercavo lavoro, e mandavo in giro dei curriculum, quel Paolo Nori di cui si leggeva nel curriculum era completamente diverso, da me che lo scrivevo, sembrava uno che aveva così voglia, di lavorare, mente io son sempre stato tendenzialmente uno che non ha voglia di far niente.
È stato allora, credo, dopo aver letto Zinov’ev, che ho capito il senso dell’espressione parmigiana «Essere falso come una lapide», che se c’è una cosa ufficiale, ufficialissima, sono le lapidi e per me, in quei primi anni, l’antifascismo ufficiale, quelle parole che sentivo dai palchi delle autorità erano un po’ così, fumose, retoriche, e false come una lapide.
Mi piaceva così poco, quell’Italia ufficiale dentro cui mi trovavo, che nel 1985, avevo 22 anni, sono andato via dall’Italia, sono andato a finire in Algeria, per un anno e mezzo, e poi in Iraq, e in Iraq mi sono trovato in una situazione che potrei definire latamente fascista, in una dittatura. Era al potere Saddam Hussein (alleato allora all’occidente e in guerra con l’Iran), e una delle prime cose che mi avevano detto, di stare attento a quel che dicevo di lui che parlare male di Saddam c’era la pena di morte.
Ecco io, di persone contro Saddam, cioè di antifascisti, in Iraq, ci ho abitato poco più di un anno, non ne ho conosciuti, o, se li ho conosciuti, non si son fatti riconoscere, da me.
Poi son tornato in Italia, mi son messo a studiare russo, mi sono laureato, e intanto che mi laureavo in Italia è andata al governo la destra, Berlusconi che ha sdoganato, così si diceva allora, il Movimento Sociale Italiano: la cosa ha comportato il fatto che le parole antifascismo e resistenza fossero quasi scomparse dai discorsi ufficiali, governativi e ministeriali, e questo, all’antifascismo e alla resistenza ha giovato, mi sembra, sono ridiventate parole vive, praticabili e praticate.
Finita l’università mi son messo a scrivere dei libri, poi a scrivere sui giornali, e nel 2012 mi hanno chiesto anche di far dei servizi brevissimi in televisione, ogni settimana mi chiedevano di andar da qualche parte, in Italia, a raccontare quel che succedeva, e una volta, in novembre, ero andato a Predappio per il raduno dei fascisti sulla tomba del duce.
Ecco io, prima di partire, di quei fascisti avevo un po’ paura, “E se fanno il saluto romano? – pensavo, – Ma non si può, ma è illegale, ma non possono mica, ma è una vergogna, ma perché non li arrestano?».
Poi eravamo andati, e eravam lì sul viale, a Predappio, era arrivata una corriera vintage, con un autista vestito in modo vintage che quando era arrivato aveva tirato giù il finestrino aveva detto, forte: «A noi!», e a me era venuto da pensare: «A noi cosa?».
Dopo c’era uno, vestito vintage anche lui, con gli stivali di pelle, il cinturone di pelle, il fez, le spalline e tutto che aveva detto: «Eia eia», e due o tre lì intorno avevano detto: «Alalà!». Che io li avevo guardati e avevo pensato «Ma cos’hanno?».
Cioè era come un mondo, sembrava un raduno come di quelli che vivono nel medioevo, cioè non che ci vivono, che lo ricreano, e questi qua, lì, quel giorno lì, ricreavano un mondo che era proprio diverso dal mondo che ci viviam noi tutti i giorni, usavano proprio anche una lingua diversa, stranissima, una lingua dove i cuori erano infiammati, le autorità erano maschie, e infaticabili, e ardimentose, e l’esercito invitto e invincibile e insonne, dove le giornate eran fauste o gloriose, dove le teste eran calde e la sovranità piena, la volontà granitica e i sangui freddi e le folle esultanti, dove tutti i bambini si chiamavan balilla, dove le certezze eran supreme, e i giuramenti sacri, e le camicie nere e dove lo spirito era prevalentemente di sacrificio e tutto questo, però, tutto questo mondo surreale conviveva, lì dove eravamo, a Predappio, con l’universo nostro, quello della crisi, quello degli sconti, del meno venti per cento, e tre calendari del duce 6 euro, che si vedeva che era una cosa che «Dài, si fa per dire».
Solo che poi, quando abbiamo incontrato un signore che aveva ottantasei anni che ci ha detto che lui era partito volontario a diciotto anni, che aveva fatto parte della guardia del duce, e che c’era il suo nome in un libro, e ci ha fatto vedere il libro, e la pagina dove c’era il suo nome, evidenziato con un evidenziatore rosa, e aveva un modo così indifeso, così ingenuo, di esporsi alla nostra telecamera che io, poi, quando ero tornato a casa che avevo trovato qualcuno in rete che si chiedeva «Ma quel raduno là, ma quelli là, che si son trovati là, ma non si può, ma è illegale, ma non possono mica, ma è una vergogna, ma non c’era nessuno che li arrestava?», ecco io, dopo che ero stato là, che avevo visto tutto quell’ambaradam là, avevo pensato che quel signore lì, di ottantasei anni, quella lì era stata la sua vita, e avevo pensato che arrestarlo, cosa vuoi arrestare, la sua vita? E come fai a arrestare una vita? Una vita non la puoi mica arrestare, al massimo ci puoi convivere, e quella lì è una cosa più difficile, avevo pensato, però secondo me è più intelligente.
Da allora, son passati quasi sei anni, non ho ancora cambiato parere.
[uscito oggi sulla Verità]

venerdì 2 Marzo 2018
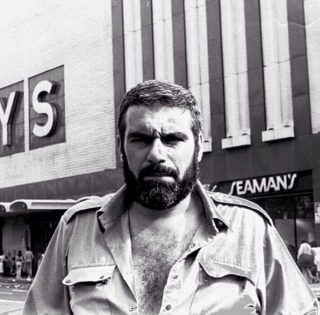
Chissà chi si ricorda di Oscar Luigi Scalfaro, un signore molto cattolico, nato a Novara nel 1918, che era stato magistrato, e poi era entrato nell’assemblea costituente, e poi era stato parlamentare dal 1946 al 1992, e poi era diventato il nono presidente della Repubblica Italiana, carica alla quale l’aveva candidato Marco Pannella, che vedeva in lui «un Pertini cattolico» e che poi aveva detto di essersi sbagliato e che Scalfaro era stato il peggiore presidente di sempre. Adesso io non voglio giudicare il valore politico del lavoro di Oscar Luigi Scalfaro, mi sento però di poter dire qualcosa sulla voce, di Scalfaro, che aveva una voce, un mondo di parlare, un’intonazione, diceva le cose con una cantilena che, quando mi capitava di sentirlo, per radio, o in televisione, a me veniva da pensare che, qualsiasi cosa avesse detto, Scalfaro, io ero contrario. Avesse anche letto un testo scritto da me, non so, l’inizio di questo pezzetto, queste poche righe in cui dico che io, qualsiasi cosa dicesse Scalfaro, ero contrario, a me, se lo sentissi, per assurdo, detto da Scalfaro, Scalfaro avrebbe un modo, di dire che io sono sempre in disaccordo con quel che dice lui, che a me verrebbe da dire «No no, io sono d’accordo, con quel che dici tu», dando il via a una spirale illogica e insensata che è meglio chiuderla subito qui, perché non è di Scalfaro, che mi voglio occupare oggi, ma di Laura Boldrini. E quel che voglio dire, di Laura Boldrini, la presidente della camera, è che lei quando parla, ha un tono, alle cose che dice dà una tale aria d’importanza, sembrano venire così dall’alto, le parole della Boldrini, che io, prima ancora che mi arrivi il senso esatto delle sue parole, a me mi viene da dire «No no, non ci siamo». Quindi, per me, parlare di Laura Boldrini, è un po’ complicato, e, di conseguenza, questo pezzetto non sarà così chiaro, e imparziale, e distaccato come quelli che l’han preceduto, portate pazienza, per cortesia, ma poca, perché di cose, sulla Boldrini, dopo questa lunga introduzione su Scalfaro, ne dirò solo e due una, la seconda, avrò solo il tempo di accennarla. La prima cosa che voglio dire riguarda la proposta della presidente della camera di introdurre una riforma linguistica che doveva portare a chiamare i ministri femmine la ministra, e i sindaci femmine la sindaca, e gli assessori femmine l’assessora e così via. La prima volta che ne avevo sentito parlare, io avevo pensato che allora, se si voleva essere almeno minimamente coerenti, bisognava chiamare un pilota maschio il piloto, uno psichiatra maschio lo psichiatro, un giornalista maschio il giornalisto, una guida alpina maschio il guido alpino, una guida turistica maschio il guido turistico, una guardia giurata maschio il guardio giurato, una vedetta, maschio, il vedetto, una sentinella, maschio, il sentinello, un pediatra, maschio, il pediatro, un barista, maschio, il baristo, un fascista, maschio, il fascisto, un ambientalista, maschio, l’ambientalisto, un obbligazionista, maschio, l’obbligazionisto, un omicida, maschio, l’omicido e che una lingua così, a me l’italiano piaceva moltissimo, e mi sembrava, come aveva detto un poeta russo che si chiama Osip Mandel’štam, «la più dadaista delle lingue romanze», ma era una lingua, che, secondo me, proprio per com’era fatta lei, non poteva rispondere sissignore agli ordini di nessuno, neanche della presidente della camera, e quando avevo sentito questa proposta a me era venuta in mente una cosa che mi sembra avesse detto un filosofo austriaco che si chiamava Wittgenstein quando aveva detto che «la lingua si cura da sé», che era una cosa che mi sembrava che fosse così, e la direzione in cui va la lingua non dipende da una persona, per quanto importante creda di essere, ma dall’insieme dei discorsi che fanno tutti i parlanti di quella lingua lì.
Un altro tema del quale si è occupata recentemente la Boldrini è l’antifascismo. Antifascismo che è diventato, un po’ a sorpresa, uno dei temi di questa campagna elettorale; la Boldrini, da una parte, sostiene che «I gruppi neofascisti vanno sciolti», qualcuno, d’altro canto, cita Pasolini e il suo «Fascismo dell’antifascismo». Io, devo dire, quando penso a Pasolini mi viene sempre in mente Manganelli, che una volta ha scritto che in certe cose che scriveva Pasolini «Quel che si nota è una tale quantità di superiorità morale nei confronti dell’universo, da essere difficilmente compatibile con una prosa comprensibile».
Ma il discorso sul fascismo e sull’antifascismo preferisco non liquidarlo nelle poche righe che mi rimangono, ci dedicheremo magari un pezzo a parte, magari già quello di domani, e oggi finisco con una frase di uno scrittore russo che in Unione Sovietica non è mai riuscito a pubblicare e che, uscito dall’Unione Sovietica e stabilitosi in America, è diventato uno dei più importanti scrittori russi del ‘900, Sergej Dovlatov. Ecco lui, Sergej Dovlatov, alla fine degli anni settanta, appena arrivato a New York, scrive: «Dopo i comunisti, quelli che sopporto meno sono gli anticomunisti».
A domani.
[Uscito ieri sulla Verità]

giovedì 1 Marzo 2018

Matteo Renzi. Ho scritto solo questo nome: Matteo Renzi, e ho già pensato: “Che due maroni”. Uno potrebbe dire «Sei prevenuto», «No – potrei rispondere io, – non sono io, che sono prevenuto, è lui, che è Matteo Renzi». Ma cosa vuol dire, essere Matteo Renzi? Claudio Giunta, in un libro uscito nel 2015 per il Mulino e intitolato, appunto, #esserematteorenzi, prova a definire il fastidio prodotto dalla renzità: «La gran parte del fastidio che gli intellettuali provano nei confronti di Renzi – scrive Giunta – è legata non alle cose che dice, che sono spesso sensate, ma, oltre alla sua faccia, alle palpebre semichiuse sugli occhi che gli danno quell’aria falsamente imbambolata», al suo «modo sguaiato di usare il linguaggio. Un mio amico snob ha avuto il coraggio di formalizzare la cosa, scherzando ma neanche troppo: “Questo è uno che dice Ci metto la faccia! È uno che dice che quando il tal dei tali parla di Firenze deve Sciacquarsi la bocca! Lo so che è assurdo, ma quando in treno sento la voce dell’altoparlante che dice Concediti una pausa di gusto! io penso a Matteo Renzi. Quando il cameriere al bar dice bollicine invece di spumante, a me viene in mente la faccia di Matteo Renzi… Poco dopo che Renzi è diventato presidente del Consiglio, Trenitalia ha sostituito l’annuncio del pranzo: adesso urlano Prova la convenienza del menù sfizioso. E io per un pezzo sono stato lì a riflettere che certamente le due cose erano collegate, che c’era una regia occulta dietro l’ingresso di sfizioso nel lessico del Frecciarossa…”». Il fatto che le cose che Renzi dice siano spesso sensate, è un’opinione di Giunta che può essere anche condivisibile: quando Renzi dice «Se perdo il referendum del 4 dicembre del 2016, mi ritiro dalla politica», dice una cosa sensata, seria, che 19 milioni 419 mila 507 persone prendono sul serio, votando No. Dopo, poi, è andata a finire come è andata a finire e Renzi è ancora in mezzo ai piedi a inventarsi delle cose che gli fanno fare bella figura. Per esempio, quando era presidente del consiglio, Renzi aveva detto «Il cuore continua a battere forte, a domandarsi come questa bellezza di cui noi parliamo può salvare il mondo, avrebbe detto il poeta, un grande poeta come Dostoevskij», e io ho mi ricordo che avevo pensato che Dostoevskij, un po’ di cose ne avevo lette, di Dostoevskij, ma di poesie, di Dostoevskij, non ne avevo mati lette, si vede che mi eran sfuggite.
E, sempre su Dostoevskij, e sempre sulla bellezza che salverà il mondo, Matteo Renzi, prima di diventare presidente del consiglio, nel 2012, in un libro che si chiama Stil novo, e che Giunta dice che è come il Mein Kampf di Renzi, in Stil Novo, nel 2012, Renzi dice che Fëdor Dostoevskij, il poeta, aveva scritto L’Idiota a Firenze, e che la celebre frase «La bellezza salverà il mondo» a Dostoevskij gli era venuta in mente quando abitava a Firenze.
E qualche anno dopo, quando avevo preso il libro Lettere sulla creatività, a cura di Gianlorenzo Pacini, che era una scelta delle lettere di Dostoevskij che trattavano della scrittura, ero capitato su una lettera del gennaio del 1869 che Dostoveskij scrive da Firenze e che comincia così: «È assolutamente necessario che io torni in Russia, qui sto perdendo perfino la possibilità di scrivere».
Che strano.
Nel libro di Renzi c’era scritto che se fai un giro a Firenze, e arrivi in piazza Pitti «una targa richiama l’attenzione, all’altezza del numero civico 22. È la testimonianza che in questa casa Fëdor Dostoevskij ha scritto L’idiota, uno dei suoi capolavori».
E poi continuava, Renzi, dicendo che gli piaceva pensare che l’idea che «la bellezza salverà il mondo», che è un’idea del protagonista dell’Idiota, il principe Myškin, a Renzi piaceva pensare che questa idea fosse venuta a Dostoevskij grazie a Firenze, «che Firenze, in qualche modo», potesse «avergli ispirato quella frase sul valore salvifico del bello», scriveva Renzi e io, allora, nel 2012, devo dire che ci avevo creduto, cioè ero stato proprio suggestionato da questa idea suggestiva esposta nel capitolo «Michelangelo e il servizio pubblico» del libro di Matteo Renzi Stil novo, solo che poi, dopo aver trovato quella frase così antipatica di Dostoevskij «È assolutamente necessario che io torni in Russia, qui sto perdendo perfino la possibilità di scrivere», ancor più antipatica se consideriamo che è stata scritta in un posto così bello come Firenze, dopo aver trovato questa frase ero andato a informarmi e avevo scoperto che L’idiota, Dostoevskij aveva cominciato a scriverlo in Russia alla fine del 1866, l’aveva continuato nel 1867 a Ginevra, a Vevey e a Milano e l’aveva finito a Firenze (dove era arrivato sul finire del ‘68) nel gennaio del 1869, quindi a Firenze Dostoevskij aveva scritto l’ultima parte del romanzo, quella più cupa, più disperata, quella del delitto, della ricaduta, quella che prende meno luce dall’idea, bellissima, che la bellezza salverà il mondo, proprio il contrario di quello che avevo capito leggendo il libro di Renzi, si vede che non ero stato attento.
[Uscito ieri sulla Verità]

mercoledì 28 Febbraio 2018

Sto rileggendo un libro di uno scrittore polacco che ha un nome impronunciabile, Szczygieł, il libro si intitola Gottland, è una storia della Repubblica Ceca e racconta, tra le altre, la vicenda di uno scrittore che si chiama Eduard Kirchberger, e pubblica romanzi pieni di «fantasmi, mostri, streghe, banditi e assassini»; poi, dopo che, in Repubblica Ceca, erano stati vietati i romanzi di questo tipo, questi libri erano stati ribattezzati «scarti» e sul portone della biblioteca Civica di Praga era comparso un cartello che diceva: «Cari lettori, siamo sicuri che approverete la nostra decisione di non dare più in prestito gli scarti (romanzi rosa, d’avventura, polizieschi) . Non compilate quindi moduli di richiesta e non chiedeteceli», dopo che era successo così, Kirchberger si fa chiamare Karel Fabian, e con questo pseudonimo scrive «storie di operai, partigiani, comunisti, e nemici del popolo». E, in questa sua nuova veste, si sente in diritto di dare dei consigli al Partito, all’unico Partito esistente allora in Repubblica Ceca, tra i quali questo «Bisogna insegnare il comunismo dai pulpiti, col Vangelo in mano».
Ecco, Matteo Salvini, a Milano, l’altro giorno, dal pulpito del suo comizio in piazza Duomo, ha insegnato il leghismo col vangelo e la costituzione in mano, e è un leghismo che io, devo dire, faccio fatica a capire, perché è diverso dal leghismo cui sono abituato io, quello di Bossi, che era, per come lo capivo io, un leghismo da romanzi rosa, d’avventura, polizieschi, un leghismo settentrionale, con un messaggio discutibile, forse, io non lo condividevo, ma molto chiaro: il nord sarebbe bene che si liberasse dalla zavorra del sud.
E era un leghismo che è finito anche per colpa, semplificando, del familismo, dei pasticci contabili che coinvolgevano anche i famigliari del leader, Umberto Bossi, ai quali erano stati concessi dei privilegi quanto meno discutibili.
Per trovare una via d’uscita da questa situazione, per fare pulizia, la Lega ha deciso di affidarsi a Matteo Salvini che, quando ancora si chiamava Kirchberger, se così si può dire, da parlamentare europeo aveva assunto come assistente, con uno stipendio di 12.750 euro al mese, Franco Bossi, fratello di Umberto, che, se le mie informazioni sono giuste, aveva all’epoca la licenza media e gestiva un negozio di autoricambi a Fagnano Olona.
E, da Kirchberger, a un festa della lega del 2009, Salvini aveva dato il via al celebre coro «Senti che puzza, scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani, o colerosi, terremotati, con il sapone non vi siete mai lavati», mentre adesso, da Fabian, ha tolto Nord dal nome Lega Nord, e ha giurato, «come fanno i presidenti del consiglio che hanno ottenuto l’incarico», sul Vangelo e sulla costituzione, e ha promesso che «da oggi – con Salvini premier – cominciano dieci anni di costruzione, di bellezza, di rispetto, di lavoro e di onestà, da Nord a Sud, nel nome dell’autonomia, delle lingue, dei profumi, delle bellezze che sono gli ottomila comuni che compongono questo paese».
Ecco a me sembra che la caratteristica di questo Salvini-Fabian, di questo nuovo Salvini, di questo Salvini 2.0, sia che tiene dentro un po’ tutto; l’altro giorno, in piazza Duomo, per esempio, ha aperto al sud e contemporaneamente ha citato, come genio, Gianfranco Miglio, il teorico della secessione, e insieme a lui Pasolini, e insieme a Pasolini Benedetto Croce, in un miscuglio che a me ricorda i discorsi di Matteo Renzi, del quale ci occuperemo domani, che ha fondato una scuola di partito che si chiama Scuola Pier Paolo Pasolini e che, nei suoi comizi elettorali, fa vedere due video, uno di Totò, l’altro di Barack Obama.
Devo dire che, anche se non le capisco, le strategie di Salvini e di Renzi sono, probabilmente, al passo coi tempi.
Per arrivare a casa mia, due estati fa, c’era un cartellone pubblicitario grande dove c’erano le pubblicità di grandi concerti, e c’era la pubblicità del concerto dei Pooh, e prima c’era stata la pubblicità del concerto di Baglioni e Morandi, e quella del concerto di Ligabue; colpito da questa cosa, ero andato a controllare, avevo scoperto che i concerti più visti nel 2016 erano stati di Laura Pausini, dei Pooh, di Baglioni e Morandi, di Ligabue, di Vasco Rossi, di Jovanotti e di Eros Ramazzotti.
E mi era venuto da pensare che se me l’avessero detto nel ‘96, vent’anni prima, che vent’anni dopo i concerti più visti sarebbero stati quelli di Laura Pausini, dei Pooh, di Baglioni e Morandi, di Ligabue, di Vasco Rossi, di Jovanotti e di Eros Ramazzotti, io avrei pensato che doveva succedere qualcosa di strano, perché succedesse una cosa del genere, tipo uno sciopero degli archivisti alla voce musica leggera.
Ecco, uno sciopero alla voce politica, alle prossime elezioni, porterebbe forse alla vittoria di Matteo Salvini o di Matteo Renzi, che anche se sono visti come portatori del nuovo, rottamatori, hanno candidato Umberto Bossi e Pier Ferdinando Casini, cioè quei romanzi pieni di «fantasmi, mostri, streghe, banditi e assassini», che qualcuno pensava non si potessero neanche più prendere in prestito nelle biblioteche.
[Uscito ieri sulla Verità]

lunedì 26 Febbraio 2018
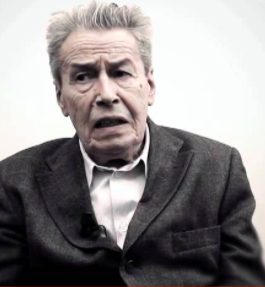
Per chi, come me, ha più di cinquant’anni, Massimo D’Alema è una parte del paesaggio politico che esiste da sempre, e descrivere le cose che esistono da sempre mi sembra molto difficile.
Qualche anno fa mi hanno chiesto di scrivere un pezzetto che parlasse dell’Emilia, e io avevo scritto che per uno che abita in Emilia, scrivere un pezzo che parli dell’Emilia era difficilissimo.
E mi era venuto in mente il periodo in cui una rivista mi aveva mandato nel Mississippi a scrivere di blues, e io ci ero andato e molti di quelli ai quali chiedevo cosa pensavan del blues mi guardavano stupiti e poi mi dicevano che loro, del blues, non ne pensavano niente.
E mi ero sentito come credo si sarebbe sentito un americano che fosse venuto in Emilia convinto che tutti gli emiliani ascoltassero il liscio, bevessero il lambrusco e mangiassero i tortellini quando si fosse accorto che c’eran degli emiliani che il liscio non lo ascoltavano e erano astemi e vegetariani.
E mi era tornata in mente una cosa che mi ha raccontato un mio conoscente bolognese che si chiama Jean Talon, il caso di quegli antropologi bolognesi che qualche decennio fa avevano invitato un cantastorie senegalese, uno che scriveva delle storie e poi le metteva in musica e le cantava ai suoi concittadini, l’avevano invitato a Bologna e gli avevano detto di osservare i bolognesi e di scrivere poi una canzone su di loro da cantare ai senegalesi e lui, tra le altre cose, aveva scritto che in Europa, al mattino, succedeva una cosa stranissima, c’era un sacco di gente che andava in giro legata ad un cane.
Che, per uno che non ha mai visto un guinzaglio, e non ha idea neanche di cosa sia, è esattamente quello che succede tutte le mattine, anche sotto casa mia, solo che vederlo è difficile, perché io son così abituato, ai guinzagli, che ho smesso di vederli, e con l’Emilia, mi sembra, succede la stessa cosa, avevo detto, e è per ovviare a questa mancanza di intelligenza nel mio sguardo, che secondo alcuni critici e alcuni teorici dell’arte esistono l’arte e la poesia.
L’arte, ha scritto una volta un filosofo che si chiama Agamben, non serve per rendere visibile l’invisibile, serve per rendere visibile il visibile, e questa cosa, con l’Emilia, a me è successa grazie alla fotografie di Luigi Ghirri, avevo detto.
Prima di vedere le fotografie di Luigi Ghirri, se pensavo all’Emilia io, oltre che al ballo liscio, al lambrusco e ai tortellini, pensavo a poche cose, ai pioppi e al fiume Po, prevalentemente; c’erano queste immagini abusate che non avevano niente a che fare con le mie giornate, abito lontano dai pioppi e dal Po, ma che erano da qualche parte nella mia testa dentro una cartellina con su scritto «Emilia».
Dopo che ho visto le fotografie di Ghirri, io mi sono accorto che in Emilia ci sono anche i distributori di benzina, i semafori, le fermate dell’autobus, la neve, i bambini che si vestono da Batman per carnevale, i gommisti, le saracinesche, le pubblicità, il cielo.
Lui, Ghirri, con le sue fotografie, è come se avesse preso con due dita l’imballaggio che avvolgeva l’Emilia, sotto casa mia, e avesse tolto dal loro imballaggio che li rendeva invisibili i distributori di benzina, i semafori, le fermate dell’autobus, la neve, i bambini che si vestono da Batman per carnevale, i gommisti, le saracinesche, le pubblicità e il cielo che c’erano sotto casa mia e io adesso, è incredibile, riesco a vederli, e la cosa è ancora più incredibile se si considera che Ghirri, sotto casa mia, probabilmente, non c’è mai neanche passato.
Ecco: con l’Emilia, il discorso torna, con Massimo D’Alema, non so bene come fare.
Nel primo pezzo di questa serie sui politici, ho citato una cosa di Kurt Vonnegut che mi viene sempre in mente quando penso alla politica: «C’è un tragico difetto nella nostra preziosa Costituzione, e non so come vi si possa rimediare – scrive Vonnegut –. È questo: solo gli scoppiati vogliono candidarsi alla presidenza. E era così già alle superiori. Solo gli alunni più palesemente disturbati si proponevano per fare i rappresentanti di classe».
Be’, D’Alema, mi sembra evidente, fin dalla prima elementare si è proposto per fare il rappresentante di classe. Si capisce benissimo. Non c’è quasi neanche bisogno che lo si dica.
D’Alema è, da sempre, parte del nostro paesaggio politico, e non una parte di cui andare fieri, secondo me.
A me è successo più volte, come a tutti, credo, di portar degli stranieri in giro per l’Italia, e non gli ho mai detto «Vieni, vieni, che ti faccio vedere D’Alema». Non ci ho mai neanche lontanamente pensato.
Mi è successo invece una volta che ho sentito un signore che, parlando di D’Alema, ne ha dato una definizione che mi è sembrata illuminante e che è anche un po’ una previsione su come andranno a finire queste elezioni. Quel signore si chiama Piergiorgio Bellocchio, e una volta, di D’Alema, gli ho sentito dire: «Dicon tutti che è così intelligente così intelligente, la prende sempre nel culo. Era meglio uno più stupido».
[uscito ieri sulla Verità]

domenica 25 Febbraio 2018

Recentemente ho ricominciato a usare i social network, e una cosa che mi è sembrata, non ci avevo mai pensato, è che, con la moltiplicazione dei mezzi di comunicazione, è impressionante come tutti parlino degli stessi argomenti e io, siccome sono un po’ un conformista, parlo anch’io degli stessi argomenti, cioè, in periodo pre-elettorale, parlo di politici.
Oggi vorrei parlare in particolare di Giulia Sarti, che è una parlamentare del MoVimento 5 stelle che poco meno di 5 anni fa, nel novembre del 2013, ha scritto sul suo profilo facebook: «Possiamo dire che siamo governati da un branco di analfabeti e fessini?».
Adesso, a parte l’uso di «Fessino», che, sono andato a vedere sul dizionario, dovrebbe voler dire «Nelle camicie fatte artigianalmente su misura, striscia di tessuto che viene applicata, cucendola a mano, in fondo alla manica», ma non credo sia questa, l’accezione usata dalla Sarti, credo piuttosto che sia un regionalismo per fesso (la Sarti è romagnola, di Rimini); io direi che, se avesse usato fessi, se avesse scritto «Possiamo dire che siamo governati da un branco di analfabeti e di fessi?», ecco, la frase della Sarti sarebbe stata apprezzabile se non altro per la chiarezza, e, devo dire, anche con fessini, viene un attimo il dubbio, ma poi uno capisce.
«Possiamo dire che siamo governati da un branco di analfabeti e fessini? – scrive nel 2013 Giulia Sarti, e poi continua: – In Italia abbiamo 23.431.319 pensionati i quali percepiscono complessivamente 270.469.483.350 euro. Ovvero poco più di 23 milioni di pensionati e una spesa di 270 miliardi. Se noi garantiamo a tutti i pensionati 5000 euro al mese ci rimangono 153.312.888.350 euro. Domanda: quanti redditi di cittadinanza possiamo garantire sapendo che la nostra proposta vale 30 miliardi?».
Il primo a commentare, su Facebook, le chiede «Onorevole, ma che calcoli ha fatto?». Il secondo, che si chiama Alessio Schiesari, precisa: «Gli altri saranno analfabeti ma tu sei discalculica. Confondi la pensione mensile con quella annuale. Garantire una pensione di 5mila euro lordi al mese (quindi 65.000 euro lordi all’anno, perché le mensilità sono 13) a 23 milioni di persone costerebbe all’incirca 1.500 miliardi di euro, poco meno del totale del Pil italiano». Allora la Sarti cosa fa? Cancella il suo post e arrivederci. Niente scuse, niente spiegazioni, manda solo un messaggio all’Huffington Post dove dice che, con quel messaggio pubblicato sul suo profilo di Facebook dove dà degli analfabeti e dei fessini ai governanti e poi fa la figura della discalculica, lei non c’entra niente [aggiornamento, una spiegazione c’è stata, è qui: clic e consiste nel fatto che la Sarti, cinque giorni dopo, dà la colpa a un hacker misterioso e molto, e male, informato sulle pensioni (vedi i commenti al post della Sarti)].
Quattro anni e mezzo dopo, nel febbraio del 2018, Giulia Sarti risulta essere uno dei parlamentari del MoVimento 5 stelle che hanno fatto un bonifico, con il quale devolvevano parte del loro stipendio a un fondo per l’aiuto alla piccola impresa, e poi hanno annullato il bonifico per riprendersi i soldi (di nascosto); quando è uscita la notizia, come si sa, la Sarti ha detto che era stato il suo ex fidanzato, e è andata a denunciarlo, e il fidanzato è andato anche lui in questura a portare le registrazioni che dimostrerebbero, secondo il fidanzato, che la Sarti sapeva tutto, dell’annullamento dei bonifici.
A me, quando ho sentito questa notizia, è venuto in mente la storia che mi avevano raccontato di uno storico inglese esperto di Russia, che si chiama Orlando Figes; a un certo punto, qualche anno fa, mi han raccontato che nei siti dove si vendono i libri online, e dove c’è uno spazio apposta per commentare, uno con un nickname che ricordava Figes ha cominciato a scrivere delle pessime recensioni sotto i libri dei colleghi di Figes dicendo «Ma che brutto libro, non come il tal libro di Figes che tratta lo stesso argomento e che invece è bellissimo». Una volta che avevano dato un premio a una collega di Figes, quel signore misterioso mi han detto che aveva scritto «Io non capisco come si fa a premiare questi libri indegni, quando ci son degli storici come Figes che, sullo stesso argomento, hanno scritto dei libri bellissimi». Quasi subito c’era stato chi aveva sospettato Figes, mi han detto, e lui aveva messo online un post in cui diceva: «Ma secondo voi, se volevo scrivere finte critiche a mio favore, sceglievo uno pseudonimo così simile al mio nome?».
Poi una collega di Figes, che si era sentita offesa da uno di questi commenti, aveva denunciato il misterioso commentatore e c’era stata un’indagine che era risalita al computer da dove partivano questi commenti: il computer di Figes.
Lui, mi hanno detto, dopo qualche ora aveva messo online un post con il quale si scusava e diceva: «Non ci posso credere, è stata mia moglie».
Il giorno dopo, dopo una nottata che non riesco a immaginare, mi han detto che aveva ammesso di essere stato lui.
Giulia Sarti, al momento in cui scrivo questa nota, si è autosospesa, che io non capisco cosa vuol dire.
Forse è come schiacciare pausa quando vedi un film.
Quando ero giovane e disperato, ho cercato più volte, sulla mia superficie corporea, un tasto che mi mettesse in pausa, o mi spegnesse. Adesso che sono vecchio e disperato non lo cerco più: sopporto.
Tanti auguri a Giulia Sarti (e anche a Orlando Figes).
[Uscito ieri sulla Verità]